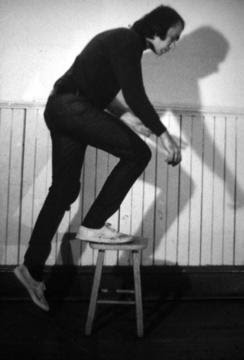Ancora su
M. Blanchot
Arte e
letteratura
Gli scritti di Blanchot sull’opera letteraria appaiono a distanza di tempo
ancora sferzanti, attuali e al contempo
tragici. Si tratta ancora di un autore largamente misconosciuto, anche in
Francia, citato il più delle volte forzatamente per attribuirgli
un’appartenenza politica che sminuisce la sua imprendibile trasversalità
intellettuale, capace di lasciarci una delle più originali riflessioni sulla
letteratura di tutto il ventesimo secolo. Direi che
i suoi scritti hanno anticipato i
tempi nel loro porsi come sostanza
dell’opera, immagine emblematica della realtà in cui viviamo, interrogazione
sullo stato di salute del mondo. Nel mondo
in cui siamo calati e immersi
quel che predomina è appunto il mostrarsi,
il fare sfoggio di sé. Importa più essere presenti nei canali di diffusione
mediatica, nella circolazione, in rete, nella rete sociale che avere a che fare
con la verità. Come se il contemporaneo
fosse il semplice presente dell’immanenza assurta ai vertici di
ogni istanza poetica ed esistenziale .
Si fa sfoggio di sé ovunque. L’arte e la moda vanno a braccetto svuotando di
senso ogni istanza di libertà e
riflessione. Basti che tutto rientri in quel che si chiama la tendenza.
Perfino i cambiamenti climatici e il
tema dell’ecologia vengono ridotti a
moda, a passarella per i fanatici delle vendite, dell’apparizione, della
pubblicità e del consumo.
Quel che chiamiamo arte contemporanea e lo abbiamo detto e scritto più
volte non è altro che la manifestazione
dell’apparire, del prevalere sull’altro e del successo; non è altro che un
prodotto di questa realtà e in quanto tale essa ci vieta perfino di fare esperienza
del niente e del nulla e del loro contrario l’assoluto e lo spirito. Ridursi a
correre dietro queste ombre della morte da
parte degli scrittori e degli artisti significa
soccombere a un regime misto di comunicazione, tecnologie mediali e capitalismo finanziario. Perfino la
politica ha abdicato al suo ruolo di visione del mondo, di garanzia etico
sociale dei diritti e dei doveri dei cittadini. Che fare ora che risuona ancora
come slogan il richiamo alla cultura da parte dei nostri leader politici senza
che si capisca cosa questa parola vuol dire ?
Ripartiamo da uno dei temi centrali del nostro blog e cioè il rapporto fra
letteratura, immagine, arte e politica richiamandoci a un intellettuale e uno
scrittore scomodo e dimenticato come Maurice
Blanchot il quale su questi temi è stato
anticipante con la sua scrittura letteraria e la sua critica anti sistemica. Importante
è comprendere la sua riflessione sulla natura dell’opera. In questo senso arte
e letteratura si mostrano nella medesima
condizione.
Per Blanchot appare essenziale alla natura dell’opera il fatto che essa continuamente
sparisca. Contribuire al suo inganno perpetuo è l’unica onestà concessa allo
scrittore e all’artista. Essi non possono
che accettare di essere un néant qui
travaille dans le néant. Ma la loro tentazione più grande rimane quella di
bucare la membrana dell’immaginario che li divide dal mondo, restituirlo come un
tutto, impedendo loro tuttavia di influire sulla realtà. Lo scrittore sembra
dirci Blanchot si riconosce nella rivoluzione. Non esistono rivoluzioni
letterarie come non esiste una letteratura della rivoluzione: la letteratura
tutta, nella sua essenza, si riflette nella rivoluzione, vi trova una
giustificazione e si fa storia.
L’angoscia dello scrittore di fronte al suo lavoro, alla sua opera, deriva dall’impossibilità
di trasformare il mondo senza trasformare se stesso. In questo senso la
rivoluzione rappresenta perfettamente la tentazione costitutiva del progetto
letterario: entrambe implicano una riflessione sulla morte come centro vuoto
della libertà assoluta che porta all’accettazione, o alla scoperta, della
propria morte come evento banale ma essenziale della condizione umana.
Com’è possibile, dunque, la letteratura e con essa l’arte? Esse sono
possibili, sembra dirci Blanchot, proprio in quanto impossibili. La letteratura
nasce nel momento in cui inizia a porsi in quanto questione e la questione che
essa pone è proprio quella del diritto alla morte. L’arte ha per ideale la rivoluzione come momento
storico in cui “la vie porte la mort et
se maintient dans la mort même” pour obtenir d’elle la possibilité et la vérité
de la parole”.
La riflessione sul ruolo dello scrittore negli avvenimenti della sua epoca,
sulla sua responsabilità civile, fu molto precoce negli articoli di
Blanchot. Egli avvertì la scomoda
dualità, il conflitto oscuro tra la sua attività di giornalista e quella di
critico. Ogni silenzio, come rifiuto della politica, è a sua volta politico:
proprio nella letteratura, in questa incapacità di uscire dallo scritto, un
autore deve saper trovare delle ragioni per agire.
Tuttavia, la questione che pone la letteratura è una questione di linguaggio ed il linguaggio
letterario è contraddittorio, rassicurante e al tempo stesso spaventoso; “la poésie ont vu dans l’acte de nommer une
merveille inquiétante”. Quando parliamo, è la morte stessa che parla. Per
dare ciò che significa, la parola deve prima
poterlo sopprimere, privarlo dal punto di vista dell’esistenza di tutto ciò che
gli restituirà sul piano ideale, astratto, dell’essere. Questa “immense hécatombe” è la condizione necessaria per poter
instaurare il regno del giorno, la distanza che, separandoci, rende possibile
la nostra intesa come soggetti logici che hanno a che fare con significati
universali, uguali per tutti.
Quando scriviamo, dice Blanchot, non ci interessiamo al Lazzaro
resuscitato, salvato e riportato alla luce, ma a quello della tomba che già
emana cattivo odore. La fisicità delle parole
viene a galla ed il linguaggio si rifugia in se stesso, si rifiuta di voler dire: “La littérature est la présence des choses,
avant que le monde ne soit, leur persévérance après que lemonde a disparu”.
Il destino della letteratura è quello di
un’ossessione, non può superarsi, andare
oltre se stessa, ma è costretta a un’incessante metamorfosi tra il movimento di
negazione che le consegna le cose come conoscibili, comunicabili, e la passione
per la realtà opaca delle parole prese fuori dal loro senso, quando il senso
stesso si fa cosa: . Impossibilità di perdere coscienza, la morte mi si
annuncia non solo come la fine con cui ha inizio ogni comprensione, ma come
l’eterno ritorno del tormento in seno all’apparenza addomesticata delle cose,
come la perdita, oltre che dell’esistenza, della mortalità stessa: morte come
impossibilità di morire.
Questa è la straordinaria rivelazione di cui ci fa dono la letteratura in quanto linguaggio che, accogliendo l’ambiguità, si fa contraddizione
irrisolvibile, possibilità perpetua di cambiare di senso e di segno alle parole.
Essa è possibilità di silenzio che nel silenzio dice qualcosa intorno alla
verità.
C’è una solitudine essenziale, dice Blanchot, che sola può permetterci di capire
qualcosa sull’arte, sulla scrittura, a patto che non la si confonda con il dramma
esistenziale di un soggetto, né con gli sforzi da lui compiuti per raccogliersi
in una dimensione psicologica creativa. Le cose vengono all’essere quando
l’essere si ritrae e al contempo esse esistono ed entrano in relazione solo in quanto
separate. Ciò significa sperimentare
l’angoscia al livello del mondo. Scrivere significa invece ritrovare l’essere
nel fondo della sua assenza, ovvero ciò che si era dovuto dissimulare per
essere un sé.
La solitudine è anzitutto dell’opera stessa, non incomunicabile ma priva di
scopo e di esigenze: ni achevée ni
inachevée: elle est.
L’unica risorsa, l’unica forma di controllo che rimane
è appunto la parola letteraria, l’unica in grado di imporre un silenzio
a questo silenzio che parla, a questo mormorio senza principio né fine: Là où je
suis seul, le jour n’est plus que la perte du séjour, l’intimité avec le dehors
sans lieu et sans repos.
La letteratura è, dunque, nei confronti del linguaggio corrente ciò che
l’immagine è in rapporto alla cosa che rappresenta: linguaggio che nessuno
parla, linguaggio immaginario non perché ricco di metafore ma perché le parole
stesse vi si fanno immagine. È il rimosso del nostro vissuto, lo scarto, la
zona d’ombra necessaria per edificare un’esperienza di senso, che ritorna e non
può non ritornare. Esperienza dell’assenza di esperienza, esperienza limite che
ritorna.
L’intera avventura del sapere occidentale continua ancora Blanchot è fondata su un paradigma ottico, che fa della
visione la facoltà in grado di fornire all’uomo una mediazione tra l’esperienza
e il suo senso, la sua verità. Proprio per questo motivo esso ha costruito il
suo logos come una struttura di rimando che fa dell’opposizione e della
distanza la condizione di possibilità di ogni relazione conoscitiva. Ma nella
solitudine della scrittura l’occultamento tende ad apparire dissimulation tend à apparaîtr. Esso è legato a una passività originaria, una
cosalità materiale e informe. Le parole sono svincolate dall’obbligo di
significare, come le immagini da quello di somigliare a qualcosa. L’immagine
che Blanchot sceglie di proporre come emblematica di questa situazione
straniante non può sorprenderci del tutto: si tratta dell’immagine della morte.
Tuttavia questa morte di cui qui si parla non è quella della moda e del suo
essere con la morte, ma la morte del
significato, la morte della parola che diventa solo rumore che induce alla
sordità, al biancore dell’immagine: immagine della morte che diviene morte mai
annunciata ma sempre procrastinata all’infinito in una nemesi storica dove il cadavere è destinato a
sparire. Ed è proprio il cadavere della letteratura, dell’arte a sparire.
Sottrarsi a questa sparizione significa
resuscitare Lazzaro, il suo corpo e
fare mergere il cadavere del nulla e la melliflua menzogna dell’immaginario; ciò che ci distoglie dalla
vera esistenza. Solo il silenzio dice che l’opera è mentre si sottrae al mondo.
Ed è proprio questa la grande lezione
di Blanchot.
0. Francesco Correggia, Fermo immagine dal video, en voiture, 1988
1. Ritratto di M. Blanchot
2. Merce Cunningham, American dancer
3. Michel
Foucault on Maurice Blanchot
4. Isadora
Duncan, Dance
5. Vito
Acconci Perverse Egalitarianism, 1979
6. German
Jauregui, dance 1994
7. Kahlen, frame dal video Body Horizon, 1980
8. Yves Klein, fontenay aux roses, France October 1960
9. Bruce Nauman, Performance, 1976
10. Gina Pane, Azione sentimentale, 1973
11. Rebecca Horn,
In addition to Concert for Buchenwald 1998
12. Martha
Graham, dance, 1982
13. Gilbert e George, Singing, Sculpture, 1992
14. Francesco
Correggia, fermo immagine dal video: I turn round to Immanuel Kant, 1996
15 Francesco Correggia, particolare installazione, Hegel, Biennale di Venezia 2009